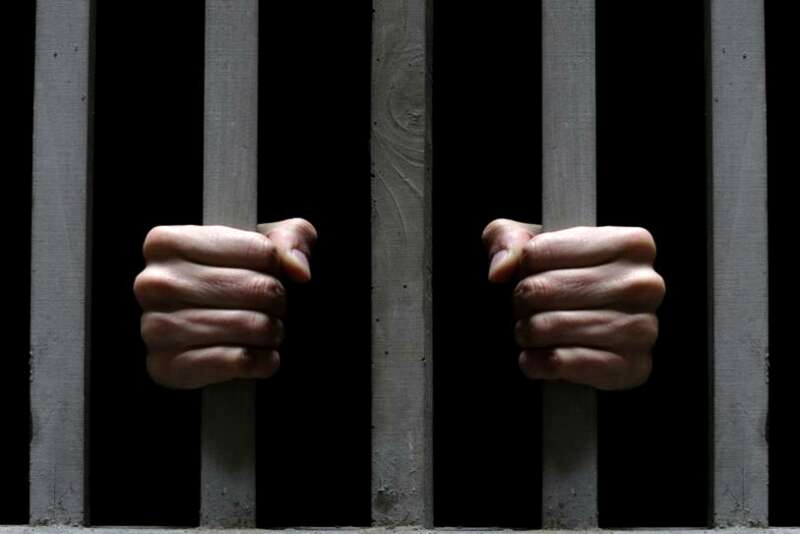L’appello è stato redatto dal Professor Andrea Pugiotto dell’Università di Ferrara ed è promosso dall’Associazione Luca Coscioni, la Società della Ragione e il Centro per la Riforma dello Stato
Il 5 dicembre, la Corte costituzionale è convocata in udienza pubblica per decidere una questione scandalosa: in assenza di contrarie ragioni di sicurezza, vietare al detenuto di «svolgere colloqui intimi, anche a carattere sessuale, con la persona convivente non detenuta», senza il controllo a vista da parte del personale di custodia (imposto dall’art. 18 dell’ordinamento penitenziario), è conforme alla Costituzione e alla CEDU?
Per chi non accetta l’orizzonte di una pena che non può essere mai contraria al senso di umanità e che deve sempre tendere alla risocializzazione del reo (art. 27, 3° comma, Cost.), scandalosa è l’idea stessa di un diritto all’intimità dietro le sbarre. Perché dentro si deve stare peggio che fuori: altrimenti che galera sarebbe? Hanno già la televisione: che cosa pretendono ancora? Le celle a luci rosse e le sezioni del carcere trasformate in postriboli?
A nostro avviso, invece, la questione è scandalosa per tutt’altre ragioni. Etimologicamente, σκάνδαλον sta per ostacolo, inciampo. Tale è la domanda riproposta dal Tribunale di sorveglianza di Spoleto a una Corte costituzionale che, dieci anni fa, diede già la sua risposta.
Investita di analoga quaestio, con sent. n. 301/2012 la dichiarò inammissibile per ragioni processuali, ma in motivazione la Consulta fu inequivoca: è «una esigenza reale e fortemente avvertita […] quella di permettere alle persone sottoposte a restrizione della libertà personale di continuare ad avere relazioni affettive intime, anche a carattere sessuale: esigenza che trova attualmente, nel nostro ordinamento, una risposta solo parziale. […] Si tratta di un problema che merita ogni attenzione da parte del legislatore, anche alla luce delle indicazioni provenienti dagli atti sovranazionali […] e dall’esperienza comparatistica che vede un numero sempre crescente di Stati riconoscere, in varie forme e con diversi limiti, il diritto dei detenuti ad una vita affettiva e sessuale intramuraria».
Che séguito ha avuto quel monito così perentorio, rivolto agli organi della legislazione?
Nella XVII legislatura, è stata approvata la delega legislativa di riforma dell’ordinamento penitenziario (legge n. 103 del 2017) che, tra i suoi principi e criteri direttivi, prevedeva espressamente «il riconoscimento del diritto all’affettività delle persone detenute e internate e la disciplina delle condizioni generali per il suo esercizio» (art. 1, 85° comma). In sede di attuazione, però, i decreti legislativi nn. 123 e 124 del 2018 non hanno introdotto alcuna disciplina in materia.
Né la postura del legislatore è cambiata nella scorsa XVIII legislatura, nonostante le pertinenti iniziative legislative presentate alle Camere dai Consigli regionali della Toscana (AS n. 1876) e del Lazio (AC n. 3488 e AS n. 2543). Entrambe non hanno avuto alcun séguito parlamentare.
Il decennale silenzio seguìto alla sentenza n. 301/2012, dunque, esprime qualcosa di più di una protratta inerzia legislativa: cela, semmai, un deliberato rifiuto di modificare lo stato delle cose.
Eppure, il «vero e proprio divieto» di esercitare l’affettività-sessualità con il proprio partner in contesto penitenziario solleva plurimi dubbi di costituzionalità. Nella sua ordinanza di rinvio il Tribunale di sorveglianza di Spoleto li argomenta, a nostro avviso persuasivamente.
Violato è l’articolo 2 della Costituzione, che garantisce i diritti fondamentali della persona sia come singolo che nelle formazioni sociali intermedie: tale è la libera espressione dell’affettività, anche all’interno del carcere in cui il detenuto svolge la propria personalità.
Violato è l’articolo 13, 1° comma della Costituzione, che garantisce la libertà personale, intesa come disponibilità del proprio corpo: la forzata astinenza sessuale, invece, ne determina una compressione non sempre giustificata da ragioni di sicurezza, traducendosi in un surplus di sofferenza oltre a quella conseguente alla legittima detenzione.
Violato è l’articolo 13, 4° comma della Costituzione, che vieta ogni violenza fisica e morale sul detenuto: «una amputazione così radicale di un elemento costitutivo della personalità, quale la dimensione sessuale dell’affettività» trasmoda, invece, in una vessazione «umiliante e degradante» non solo per il recluso, ma anche per il suo partner.
Violato è l’articolo 27, 3° comma della Costituzione, che esige pene improntate a umanità e finalizzate alla rieducazione: invece, l’inumana privazione dell’intimità sessuale fa regredire il detenuto a una «dimensione infantilizzante» e produce «conseguenze desocializzanti».
Violati in solido sono gli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione, posti a tutela delle relazioni familiari: il divieto della sessualità intramuraria, invece, «logora i rapporti di coppia», anche a danno della serenità dei figli, e pregiudica la «possibilità di accedere alla genitorialità» ove desiderata.
Violato è l’articolo 32 della Costituzione, che assicura il diritto alla salute: prevedibili, invece, sono le negative conseguenze psico-fisiche su un adulto costretto a una prolungata e coatta astinenza sessuale.
Violato è l’articolo 117, 1° comma, che impone il rispetto degli obblighi internazionali pattizi: la preclusione di relazioni sessuali in carcere, invece, contraddice il divieto di trattamenti inumani e degradanti (art. 3 CEDU) e il diritto al rispetto della propria vita privata e familiare (art. 8 CEDU).
Tali e tante criticità costituzionali – a nostro parere – possono riassumersi nella comune lesione al principio supremo della dignità del detenuto.
Il diritto all’affettività, infatti, è stato inquadrato dalla Consulta tra le libertà costituzionalmente garantite (sentenza n. 561/1987). Ma se il diritto all’intimità sessuale (incapsulato nel diritto all’affettività) ha valore costitutivo della dignità umana, non lo si può negare a una persona in ragione della sua condizione di cattività, che – come attestano l’esperienza comparata e le fonti di soft-law transnazionali – non è necessariamente incompatibile con il suo esercizio.
Né il diritto all’affettività-sessualità del detenuto può ritenersi soddisfatto grazie ai periodici permessi premio (quarantacinque giorni all’anno, al massimo). Da un lato, sono molti i detenuti che, de jure o de facto, non accedono né possono aspirare a queste eventuali parentesi extrapenitenziarie. Dall’altro, una simile alternativa piega a un’impropria logica premiale il godimento di un diritto fondamentale: come se l’esercizio della sessualità dovesse meritarsi, spettando solo ai “buoni” e non anche ai “cattivi”.
Siamo convinti che vi siano ragionevoli motivi per attendersi, questa volta, un sindacato nel merito della questione di costituzionalità sollevata. Appare poco convincente opporvi l’argomento piglia-tutto della political question (art. 28, legge n. 87 del 1953), preclusa alla Corte costituzionale. Alla Corte, infatti, non viene chiesta la creazione di un nuovo diritto fondamentale, bensì la rimozione di una discriminazione contraria a Costituzione derivante da una (voluta e persistente) omissione legislativa. Nella logica della rigidità costituzionale, è dovere della Consulta applicare i limiti che la Costituzione impone all’intero ordinamento, composto da disposizioni esplicite come da norme implicite (ma viventi).
Così come – a nostro parere – non si giustificherebbe la soluzione di un rinnovato monito al legislatore, foss’anche nella forma rafforzata di un’incostituzionalità prospettata ma differita ad altra udienza: tecnica che la Consulta ha già adoperato in ambito penitenziario, affrontando l’istituto del c.d. ergastolo ostativo (ordd. nn. 97/2021, 122/2022, 227/2022). A che pro, a distanza di dieci anni dal precedente monito che il legislatore non ha semplicemente ignorato, ma deliberatamente disatteso?
Non mancano, infatti, alla Corte costituzionale altre tecniche decisorie idonee a risolvere, nel merito, il caso in esame.
Una è prefigurata dal Tribunale di sorveglianza di Spoleto, laddove segnala l’articolo 19 dell’ordinamento penitenziario minorile che prevede espressamente la possibilità per il recluso di usufruire di incontri (due al mese) prolungati (da quattro a sei ore) «con i congiunti o con le persone con cui sussiste un significativo legame affettivo», da svolgersi in unità abitative appositamente attrezzate all’interno degli istituti, pensate per riprodurvi un ambiente domestico.
Secondo un recente (ma già consolidato) orientamento della giurisprudenza costituzionale, è possibile dichiarare ammissibile e accogliere una quaestio laddove sia rinvenibile nell’ordinamento una «soluzione costituzionalmente adeguata, benché non obbligata» (sentenza n. 40/2019); soluzione normativa che la Corte può imporre transitoriamente, in attesa del futuro intervento del legislatore. È una nuova tecnica manipolativa, a rime possibili, nata nell’ambito del sindacato di costituzionalità sulla misura delle pene, ma che la Consulta ha già esteso anche ad altri ambiti ordinamentali (cfr. sentenza n. 62/2022, in tema di riequilibrio della rappresentanza di genere). Dunque, generalizzabile.
Ebbene, l’articolo 19 citato potrebbe rappresentare il gancio normativo necessario alla Corte costituzionale per pronunciare la sentenza additiva richiesta dal giudice remittente.
In alternativa, l’accoglimento della quaestio potrebbe tradursi in una sentenza additiva di principio.
Con simili decisioni, la Corte costituzionale dichiara illegittima l’assenza di una disciplina idonea ad assicurare l’effettività di un diritto costituzionalmente riconosciuto. In prospettiva, il giudicato costituzionale vincola il legislatore ad introdurla. Nel frattempo, immette nell’ordinamento un principio cui fare già riferimento in sede applicativa, per porre rimedio all’illegittima omissione.
La garanzia interinale del diritto alla sessualità inframuraria così riconosciuto, dunque, graverà sui giudici di sorveglianza e sull’amministrazione: quest’ultima, in particolare, potrà provvedere – tramite circolare o per via regolamentare – alla definizione di modi e limiti del diritto alla sessualità inframuraria.
Fino ad oggi, la privazione dell’affettività-sessualità ha rappresentato un’autentica e indifferenziata pena accessoria. Il codice penale non la contempla, Nessun giudice l’ha mai irrogata. Eppure, è regolarmente inflitta al soggetto recluso (e al suo partner incolpevole).
Noi pensiamo si tratti di una primitiva sanzione corporale, contraria al disegno costituzionale delle pene. Confidiamo che il Giudice delle leggi, viva vox Constitutionis, la rimuova dall’ordinamento penitenziario perché, anche dietro le sbarre, le parole amore e Costituzione non sono incompatibili.

L’Associazione Luca Coscioni è una associazione no profit di promozione sociale. Tra le sue priorità vi sono l’affermazione delle libertà civili e i diritti umani, in particolare quello alla scienza, l’assistenza personale autogestita, l’abbattimento della barriere architettoniche, le scelte di fine vita, la legalizzazione dell’eutanasia, l’accesso ai cannabinoidi medici e il monitoraggio mondiale di leggi e politiche in materia di scienza e auto-determinazione.