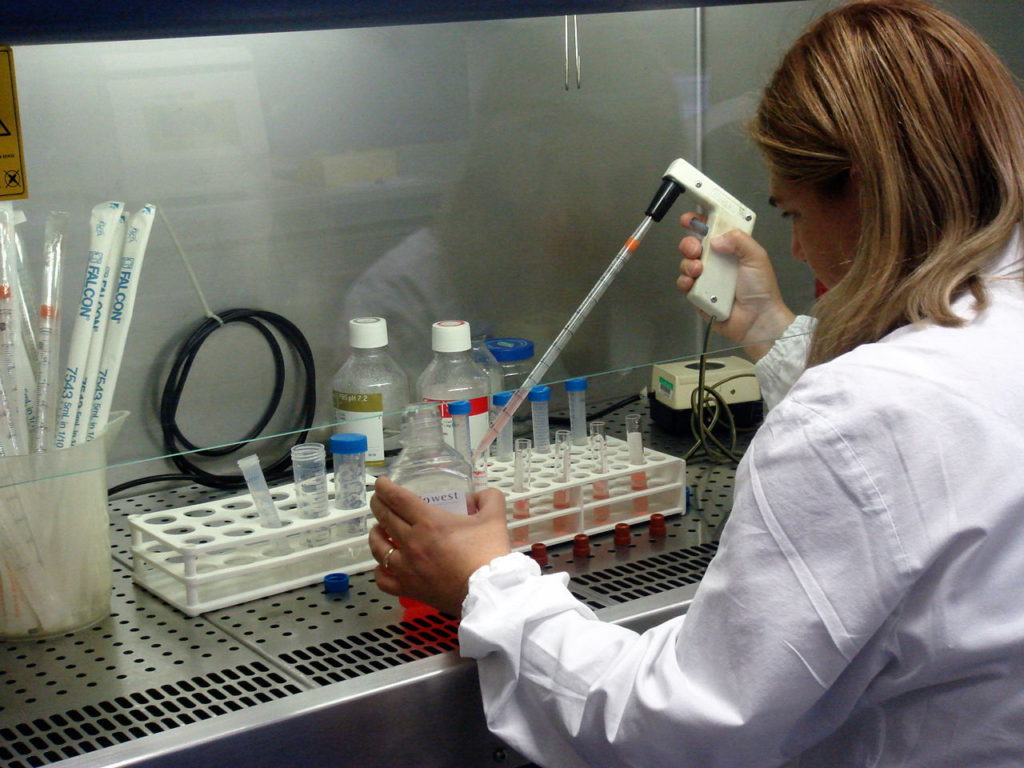Mentre qualcuno parla di abolizione delle tasse universitarie, si tace su ciò che sta davvero strangolando la ricerca in Italia: la burocrazia.
Attorno all’università italiana ruotano almeno un paio di immagini, scolpite nelle teste dei cittadini (tra poco elettori) grazie ad una efficace, ma non proprio generosa, azione degli organi di stampa. Immagini che la dipingono strutturalmente e da decenni in grande difficoltà e che non sembrano mostrare alcun segnale di miglioramento.
Da un lato le storie di baronie, privilegi, concorsi truccati e procedure poco trasparenti, che, pur essendo un reale problema in alcune realtà, rischiano di distruggere gran parte della credibilità che il nostro sistema accademico meriterebbe di avere. Dall’altra, la cronica e mai abbastanza ripetuta mancanza di fondi, risultato di una stagione di tagli e provvedimenti fatti con l’accetta, che, negli ultimi 10 anni, hanno portato alla perdita di migliaia di posti di lavoro, tra ricercatori e professori nelle Università e negli istituti di ricerca.
Visti da fuori dai confini nazionali, i problemi dell’accademia italiana e le immagini ricordate sopra assumono contorni molto più sfocati (o sfumati). Quindi, quando capita di vedere un’offerta di lavoro come ricercatore in Italia pubblicizzata in ambito internazionale un po’ di curiosità non può che venire. Ecco una piccola storia.
È il caso di un bando, pubblicizzato tramite una mailing list di respiro europeo, presso un prestigioso ateneo del nord Italia. Si tratta di una posizione di ricercatore a tempo determinato. Anzi, di 12 posizioni, in diversi settori: non capita spesso.
Ricerca Universitaria e Burocrazia
La mail con cui si annuncia il bando è dell’8 gennaio, mentre dal sito dell’università si deduce che il materiale è online dal 13 dicembre. Controlliamo le scadenze: 1 febbraio. Non c’è molto tempo, certo, ma comunque qualche settimana l’abbiamo.
Sempre per curiosità, visto che il bando è stato pubblicizzato in inglese, apriamo la voce “Summary for non italian applicants” (riassunto per candidati non italiani). E qui troviamo il vero scoglio. Nel caso di dottorato di ricerca conseguito all’estero, il candidato dovrà provvedere a dimostrare di avere sufficiente documentazione per ottenere l’equipollenza/equivalenza del titolo di studio con quello italiano. Il tutto spiegato con la misteriosa formulazione “equipollence/equivalence-recognition of degrees”. Abbastanza intimorente, non c’è che dire. Tutti sappiamo che il dottorato di ricerca è il primo gradino della carriera accademica, quindi presumibilmente la quasi totalità dei candidati stranieri sarà in possesso di un dottorato di ricerca conseguito all’estero.
Continuando quindi a comportarci come un potenziale candidato non italofono, proseguiamo la lettura alla ricerca delle istruzioni del caso. A quanto pare, il candidato può alternativamente presentare documentazione di equivalenza o di equipollenza (da ricercatore digiuno di linguaggio giuridico, ci sfugge la sottile differenza tra le due cose). Seguiamo quindi il link nel documento che promette di darci tutte le informazioni necessarie per l’equivalenza. Nulla, vicolo cieco: il link ad una pagina del “Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione” (completamente in lingua italiana) ci restituisce un triste “404 – Pagina non trovata”. Non ci diamo per vinti: torniamo al bando dell’ateneo e seguiamo il secondo link, alla voce equipollenza. Questa volta il link è ad una pagina del Miur (Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca). La pagina, in italiano, contiene un fitto elenco di riferimenti normativi sui dottorati di ricerca. Cerchiamo la parola chiave “equipollenza” e, finalmente, troviamo un file PDF che ci spiega la procedura nel dettaglio. In realtà di PDF ce ne sono un paio, ma decidiamo che il file intitolato “Equipollenza dottorato estero ai fini della concessione del congedo straordinario retribuito ai dipendenti pubblici (Legge 476/1984, art. 2)” non fa al caso nostro.
Leggendo le istruzioni – in italiano, ma facciamo finta di esserci fatti aiutare da un collega magnanimo che parli questa lingua – scopriamo che per l’equipollenza del dottorato occorre ottenere anzitutto l’equipollenza del titolo di studio di secondo livello che in Italia abiliti alla partecipazione ad un corso di dottorato. In altre parole se laurea triennale, laurea specialistica o master, sono stati conseguiti all’estero, occorre prima farsi riconoscere equipollenti quelli. Un bel colpo!
La norma kafkiana ha in serbo altre sorprese: ormai calati nella parte del ricercatore inglese (o francese, tedesco, spagnolo…) che disperatamente vorrebbe partecipare ad un concorso pubblico italiano, continuiamo con la lettura. Scopriamo allora che occorre produrre una “dichiarazione di valore”, rilasciata dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana all’estero competente per il territorio presso il quale ha sede l’Università in cui si è conseguito il titolo, dalla quale risulti “la durata legale minima del corso di dottorato frequentato come prevista dall’ordinamento universitario estero, e la natura giuridica dell’Università estera”.
Quindi il nostro ricercatore francese che, poniamo, ha ottenuto un dottorato di ricerca da una delle università di Parigi, dovrebbe recarsi presso l’ambasciata italiana di Francia per farsi certificare che sì, davvero il titolo ha valore e che sì, davvero l’università era autorizzata a rilasciarlo! E deve ritenersi uno dei fortunati: insieme ai titoli rilasciati in Belgio, Danimarca, Irlanda e Germania, quelli francesi sono gli unici a non dover ottenere “legalizzazione e Postilla dell’Aja”.
Prima di gettare la spugna, troviamo un’ultima perla: scopriamo che al fine del riconoscimento la durata minima legale del corso di dottorato frequentato non deve essere inferiore a quella minima di tre anni prevista dalla normativa italiana. Che fare, quindi, se non esiste una durata minima legale nel paese in cui si è ottenuto il titolo (ad esempio, negli Stati Uniti) e se si è ottenuto il dottorato in meno di tre anni? Game over.
Ci ritiriamo in buon ordine e dichiariamo la resa. Improvvisamente, le difficoltà e le storture del sistema italiano, che ci apparivano sfumate e sfocate da lontano, ci sembrano di una nitidezza estrema. Chiudiamo la pagina, convinti che il nostro fantomatico collega straniero l’abbia fatto già da molto: le tre settimane di tempo prima della scadenza del bando appaiono ora paurosamente brevi. Qualcosa ci dice che, tra i candidati, non ci saranno affatto ricercatori non italiani. Anzi, che non abbiano conseguito un titolo in Italia. Ovviamente, saremmo felicissimi di avere torto, e di scoprire che questa incredibile burocrazia non è riuscita a spaventare dei coraggiosi colleghi americani o inglesi o francesi eccetera eccetera.
Prima che qualcuno si affretti a contestare la nostra ricostruzione dei fatti, facciamo un paio di chiarimenti.
Sì, è vero che l’intero iter non deve essere seguito per la semplice partecipazione al concorso. Ma è anche vero che il mostro burocratico che si apposta appena oltre il concorso non può essere evitato, e dietro quell’ambigua frase “il candidato dovrà mostrare di avere sufficiente documentazione per ottenere l’equipollenza o l’equivalenza del titolo” si celano potenzialmente infinite motivazioni che si possono trovare per rigettare una candidatura dall’estero. Vogliamo anche sottolineare che, purtroppo, non c’è nulla di speciale nel caso dell’ateneo in questione, che quindi decidiamo di non citare esplicitamente. Questa storia l’avremmo potuta raccontare prendendo come spunto un bando scritto da una qualsiasi università italiana, che si limiti a seguire le procedure previste dalla legge.
Si dirà che l’equipollenza o l’equivalenza (continua a sfuggirci la differenza, chiediamo perdono ai colleghi di giurisprudenza) sono necessarie per evitare di riconoscere titoli di studio ottenuti in paesi con standard troppo diversi dal nostro. Ma è procedura necessaria all’interno dell’Unione Europea? Possibile che, nel 2017, non ci si una vera armonizzazione europea sui titoli di studio di alto livello, con riconoscimenti automatici?
Ma forse il problema è più profondo di così. A cosa serve, in fondo, il riconoscimento del titolo? In Francia, un paese per certi versi simile al nostro per organizzazione del sistema universitario, per ottenere la “Qualification aux fonctions de maître de conférences” o di “Professeur des universités”, ossia l’abilitazione per poter concorrere alle posizioni di professore o da ricercatore a tempo indeterminato, l’unica documentazione supplementare da presentare in caso di titolo ottenuto all’estero è una autocertifcazione, in cui il candidato dichiara che il titolo è equivalente ad un dottorato francese. Tutto qui. Sarà poi compito dell’amministrazione (non del ricercatore!) fare le opportune ricerche e chiedere, eventualmente ed in un secondo momento, ulteriori pezze giustificative. In Germania addirittura, proprio per favorire l’accesso di ricercatori stranieri nel sistema, dal 2002 l’austera procedura di Habilitation, l’abilitazione tradizionale, non è più necessaria per poter partecipare ai concorsi pubblici da professore: sarà compito della commissione valutare se i titoli presentati (incluso eventualmente un dottorato all’estero) sono sufficienti o meno.
Spesso, nella comunicazione con il grande pubblico, gira molta retorica sul problema dei cosiddetti “cervelli in fuga”. Certamente, a volte per opportunità legate ai finanziamenti, altre volte perché fare ricerca in certi ambiti è molto difficile o praticamente impossibile in Italia (complici alcune leggi profondamente sbagliate), in molti hanno scelto di andare oltre confine. Ma non possiamo dimenticarci che il concetto di confine non è proprio del mondo della Scienza: è impensabile oggi non avere collaborazioni internazionali, non viaggiare, non incontrare colleghi da altri paesi. Una ricerca autarchica non potrebbe che essere destinata rapidamente alla totale irrilevanza.
Piuttosto che una sterile ricerca del “rientro degli italici cervelli” (maldestramente portata avanti con discutibili iniziative), quindi, un’accademia realmente sana dovrebbe favorire il più possibile la circolazione di persone e di idee. Ben vengano dunque ricercatori stranieri in Italia, e ben vadano i ricercatori italiani all’estero! Ma il primo passo, affinché i flussi in uscita non siano drammaticamente superiori a quelli in entrata, oltre ad un sacrosanto ripensamento dei modelli di finanziamento, sarebbe quello di rimuovere gli ostacoli più semplici e che meno hanno a che vedere con il mondo della ricerca scientifica. Quelli burocratici.
Una riforma, questa sì, a costo zero.
Federico Binda è membro di giunta dell’Associazione Luca Coscioni.
Classe 1988, ha studiato matematica prima presso l’Università degli Studi di Milano, poi a Parigi e infine in Germania, dove ha conseguito un dottorato di ricerca in geometria algebrica nel 2016. Attualmente, lavora come ricercatore presso l’Università di Regensburg (Ratisbona, Germania). Cura, all’interno della trasmissione “Il Maratoneta” su Radio Radicale uno spazio di approfondimento su notizie di attualità internazionali dal mondo della ricerca scientifica.