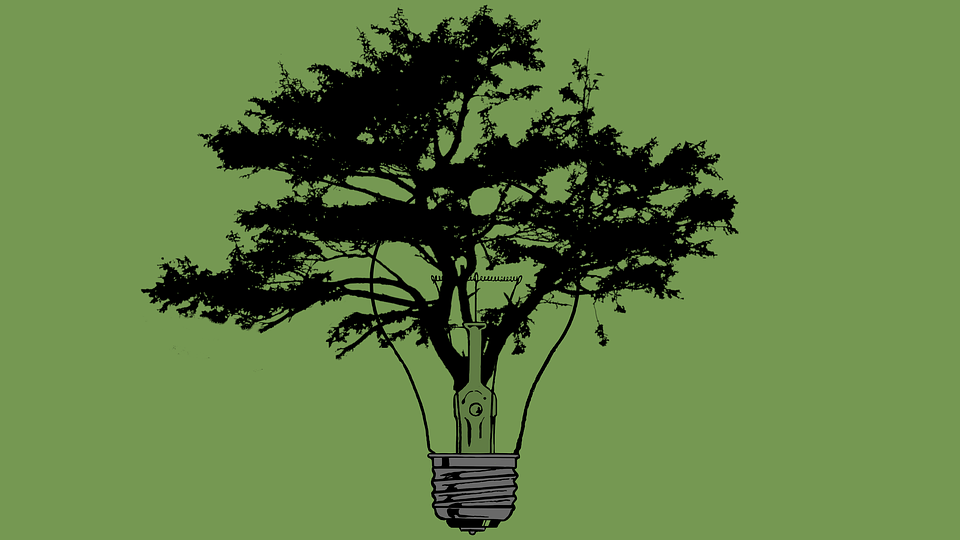Episodio 3
Da qualche anno si parla di “diritto umano alla scienza”, un diritto vecchio quanto la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 1948, ampliato nel Patto Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali negli anni ‘60 che si compone di (almeno) tre elementi: libertà di ricerca, condivisione della conoscenza prodotta (o in corso di produzione) e il diritto a godere dei benefici del progresso scientifico e delle sue applicazioni.
Dalla primavera 2020 le Nazioni unite hanno pubblicato un “commento generale” sulla scienza, il numero 25, che chiarisce ulteriormente quali siano gli elementi del diritto, le sue implicazioni ed effetti, oltre che naturalmente, il dettaglio degli obblighi internazionali degli Stati che hanno ratificato il Patto.
La scienza è per definizione una “impresa” di partecipazione, con un suo metodo che prevede la condivisione di quanto “scoperto” o “inventato” perché possa essere verificato, duplicato e/o falsificato all’interno di una comunità di esperti per arrivare alla formazione di un consenso basato sull’analisi dei fatti. Questo “metodo scientifico” non può non tenere conto di implicazioni etiche di valori come l’integrità, la solidarietà e, naturalmente, la pace.
Da sempre gli scienziati sono stati tra i più attivi a organizzarsi per evitare le guerre. Anche chi fu coinvolto nel Manhattan Project che sviluppò la bomba atomica si pose il problema della morte e devastazione che questa nuova arma avrebbe provocato. Gli e le scienziate, nella stragrande maggioranza dei casi di origine europea, che lavorano alla bomba lo fecero affinché venisse reso noto il loro lavoro con il fine di far conoscere ai nazisti che gli USA erano arrivati primi e che sarebbero stati pronti a usarla contro la soluzione finale. Nella stragrande maggioranza dei casi non erano a favore del suo impiego. La decisione di sganciarne due, su Hiroshima e Nagasaki, fu del Presidente democratio Truman, che aveva combattuto nella Prima Guerra Mondiale. I più importanti fisici che lavoravano per Hitler si impegnarono (senza farlo capire lì per lì) per rallentare lo sviluppo della bomba tedesca in modo da non renderla disponibile al Führer ormai arrivato alla fine del suo disegno criminale.
Profondamente scioccati dalle devastazioni che avevano contribuito a inventare, molti dei coinvolti nel Manhattan Project hanno rivisto il loro ruolo di scienziati continuando la loro opera pubblica per dissuadere l’uso delle armi atomiche che in parte ha purtroppo fallito ma che ha portato agli accordi di non proliferazione durante la Guerra Fredda.
Ma non è solo la “scienza bellica” che può far iniziare, o cessare, le guerre. Ci sono altre “ragioni” per cui i capi di governo attaccano altri stati e, tranne criminali deliri di onnipotenza, ci sono “armi” geo-economiche che glielo permettono. Nel caso di Putin è la ricchezza del sottosuolo della Russia nonché la posizione di forte dominio in altri settori (grano, ferro, precursori chimici). Questi frutti della natura, e dell’ingegno umano, gli hanno consentito di agire nella (per ora) più totale impunità. In attesa che si riesca a organizzare una reazione fondata sul rispetto del diritto internazionale e la lotta contro l’impunità, ci sono altre misure che possono esser prese per depotenziare la ricchezza, e (almeno apparente) sicurezza di Putin.
Il 7 aprile il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione che propone a Consiglio e Commissione europea di procedere con un embargo, anche totale, del gas russo. Si tratta di un documento non vincolante e votato a maggioranza ma che segnala una chiara presa di posizione di chi viene eletto in Europa che non potrà non avere comunque delle ripercussioni politiche all’interno delle istituzioni europee.
Però, saremmo davanti a una guerra di aggressione lanciata da chi fornisce quasi il 40% del gas all’Europa se negli anni avessimo ascoltato le raccomandazioni dell’Intergovernmanetal Panel on Climate Change (IPCC) che da 30 anni propongono una radicale revisione degli investimenti in fonti energetiche meno inquinanti o rinnovabili sulla base di argomenti scientifici?
Non solo non si sono ascoltate le letture da “fine del mondo” degli esperti sul clima, ma, neanche davanti a stagioni stravolte, carestie, inondazioni, trombe d’aria continue o incendi che hanno devastato intere regioni come negli USA, si è continuato a privilegiare i combustibili fossili firmando fior di accordi coi peggiori regimi purché i nostri inverni fossero debitamente riscaldati e le estati ringrescate. E la nostra industria possa operare.
E oggi, che piano piano ci si vuole sganciare dal gas russo, a chi ci si rivolge? Ad Algeria, Azerbaijan, Libia e Qatar. Nessuno di questi stati è una democrazia consolidata, almeno due (Azerbaijan e Libia) sono stati interessati da recentissimi conflitti armati interni, mentre il Qatar finanzia insorgenze tra il Medio Oriente e l’Africa e una TV che le fomenta; l’Algeria ha votato contro l’espulsione della Russia dal Consiglio Onu sui Diritti umani mentre il Qatar si è astenuto. Possibile che non ci sia alternativa energetica che non sia quella di cadere dalla padella nella brace?
La Comunità internazionale si è data degli obiettivi ambiziosi di sviluppo sostenibile da conquistare entro il 2030; da qualche settimana però siamo purtroppo confrontati con decisioni che devono avere ricadute efficaci nel giro di mesi. Chiaramente il problema dell’indipendenza delle fonti energetiche non è solo legato al depotenziamento dei regimi autoritari che ce le vendono, esso ha sullo sfondo un’altra tragedia annunciata e su cui non si sta facendo abbastanza – e ancora meno si farà visto che è stato deciso addirittura il ritorno al carbone nazionale – il riscaldamento globale. E non è escluso che anche questo possa esser motivo di nuovi conflitti.
Se gli Stati dell’Onu mantenessero gli impegni presi a proposito degli approvvigionamenti energetici e confermassero i finanziamenti promessi e determinati a livello nazionale previsti per il 2030, ai sensi dell’accordo di Parigi, il riscaldamento planetario futuro si potrebbe ridurre di qualche grado,sempre troppo poco rispetto alle riduzioni delle emissioni necessarie per mettere il mondo nelle condizioni di ridurre la temperatura di di 2°C o 1,5°C entro il 2100 ma almeno sarebbe un segnale chiaro e invece… La scienza ci dice che la stabilizzazione della temperatura media globale richiederà la riduzione delle emissioni di anidride carbonica (CO2) a zero, se torniamo al carbone nazionale o incitiamo l’Arabia saudita ad aumentare la produzione di petrolio per non comprare il gas russo è chiaro che tutto sarà da rivedere.
Il terzo gruppo di lavoro del sesto rapporto di valutazione dell’IPCC fornisce una visione dettagliata dei possibili futuri, afferma per esempio che le politiche attuali metterebbero il mondo sulla buona strada per una riduzione di circa 3°C o poco al di sotto di 3°C entro il 2100. Il documento ricorda che le incertezze del sistema climatico significano che un riscaldamento fino a 2,3°C o superiore a 4°C non può essere completamente escluso. Lo studio però è stato preparato prima della guerra contro l’Ucraina.
Chi invece si è dedicato ad sensibilizzare una partecipazione popolare sul da farsi immediato è l’Agenzia internazionale per l’energia (AIE) che, di fronte alla crisi energetica globale innescata dall’invasione russa dell’Ucraina ha individuato dei punti precisi per ridurre l’uso del petrolio con 10 azioni che possono essere intraprese individualmente per ridurre la domanda di petrolio con un impatto immediato e come aiutare a portare la domanda di petrolio su livelli più sostenibili nel lungo termine.
Il gruppo di lavoro dell’IPCC dedica una sezione ai “percorsi illustrativi di mitigazione” attingendo da un database di oltre 3.000 percorsi diversi di emissioni future tra loro con modelli di valutazione integrata che esaminano le tecnologie energetiche, le scelte di utilizzo dell’energia, i cambiamenti nell’uso del suolo e le tendenze della società che causano o prevengono le emissioni di gas serra. Da nessuna parte però si rintraccia l’ipotesi di come cambierebbero certe dinamiche, o i modelli stessi, nel caso di un conflitto armato né di una guerra di aggressione lanciata da uno dei maggiori produttori di gas al mondo che, tra le altre cose, ha il potere di veto al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni unite.
Studi, ricerche, rapporti istituzionali, modelli teorici, analisi, previsioni e raccomandazioni sono disponibili da molto tempo, quel che manca è l’attenzione politica alla scienza. Troppo spesso infatti la scienza viene ritenuta un argomento per esperti. Se è vero che il metodo scientifico si basa sulla revisione tra persone con pari competenze specifiche – che dal momento in cui pubblicano le proprie ricerche si aprono allo scrutinio di chiunque – le decisioni su dove, per esempio, comprare il gas, o investire in ricerca e sviluppo per produrre energia da fonti alternative o rinnovabili, resta in capo ai decisori politici.
Se il dibattito pubblico non viene organizzato sulla base di “evidenze scientifiche”, e la politica continua ad anteporre sempre la Ragione di Stato immediata a un futuro sostenibile o l’interesse nazionali prevale sui diritti umani dei popoli che vivono in regimi antidemocratici, alla fine continueremo a subiremo le nefaste conseguenze indirette dell’aver ignorato la scienza.
La guerra di Putin all’Ucraina, che in molti ci dicono essere una guerra contro i “nostri valori”, in realtà è una guerra finanziata dalla connivenza con chi abusa sistematicamente della propria posizione economica dominante, uno stato di fatto frutto della mancanza del rispetto dei “nostri” obblighi internazionali quelli relativi ai valori di libertà e democrazia tanto sbandierati che, oltre ad arricchire autocrati e oligarchi, li rende intoccabili anche di fronte alle violenze e distruzioni che causano.